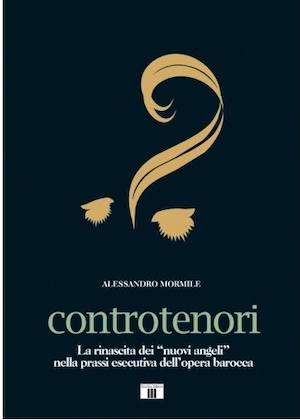•
Hector Berlioz, Le Carnaval romain, Ouverture caractéristique op. 9
Allegro assai con fuoco – Andante sostenuto – Poco animato – Tempo I, Allegro vivace
Camille Saint-Saëns, Concerto n. 1 in la minore per violoncello e orchestra, op. 33
Allegro non troppo
Allegretto con moto
Un peu moins vite. Molto allegro
Ottorino Respighi, Fontane di Roma. Poema sinfonico
La fontana di valle Giulia all’alba – Andante mosso
La fontana del tritone al mattino – Vivo, un poco meno allegretto, Più vivo gaiamente
La fontana di Trevi al meriggio – Allegro moderato, Allegro vivace, Più vivace, Largamente, Calmo
La fontana di villa Medici al tramonto – Andante, Meno mosso, Andante come prima
Ottorino Respighi, Pini di Roma. Poema sinfonico
I pini di villa Borghese – Allegretto vivace. Vivace
I pini presso una catacomba – Lento
I pini del Gianicolo – Lento
I pini della Via Appia – Tempo di marcia
•
Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Andrés Orozco-Estrada direttore, Ettore Pagano violoncello
Torino, Auditorium RAI Arturo Toscanini, 8 gennaio 2026
Roma tra Ottocento francese e Novecento italiano
Il primo concerto del 2026 della stagione RAI è una vera esplosione di colori, rumori, immagini: una serata che sembra aver deciso di rendere omaggio a Roma senza troppi giri di parole, anzi con un certo gusto per l’effetto speciale. Si parte infatti con Le Carnaval romain di Hector Berlioz, ouverture “caratteristica” del 1844 ricavata dal Benvenuto Cellini, opera di quattro anni precedente e di molto minor fortuna. Come spesso accade, il derivato ha avuto più successo dell’originale: l’ouverture è rimasta stabilmente in repertorio, l’opera continua a vivere di resurrezioni intermittenti.
In un altro brano in programma quella sera del 3 febbraio 1844, Hymne sacré, comparve per la prima volta uno strumento appena nato, il sassofono di Adolphe Sax, inventato solo quattro anni prima. Ma torniamo al Carnevale, che affonda le radici in quel saltarello corale che già nel 1838 aveva messo in crisi più di un direttore, impreparato al virtuosismo e alla spregiudicatezza della scrittura berlioziana. Accennato all’inizio, il saltarello lascia spazio a un Andante sostenuto dominato dalla melodia del duetto d’amore tra Benvenuto e Teresa, affidata alla sapienza orchestrale del compositore e al lungo, languido assolo del corno inglese. Poi la danza riprende possesso della scena: la frenesia cresce, la strumentazione scintilla, l’ebbrezza diventa quasi orgiastica in un finale travolgente che ci scaraventa nelle strade della Roma di primo Ottocento, invase dal carnevale. Da una parte il cupo dominio della Chiesa, dall’altra l’energia dionisiaca del popolo: Berlioz non sceglie, mette tutto insieme. L’Orchestra Sinfonica Nazionale RAI, guidata dal suo direttore principale Andrés Orozco-Estrada, restituisce con grande efficacia l’esuberanza e l’eccesso di una pagina orchestrale che vive di colori abbaglianti e armonie tutt’altro che innocenti.
Si resta in Francia anche nel secondo brano in programma, ma si cambia epoca. Siamo nel 1873 e Camille Saint-Saëns, fondatore della Société Nationale de Musique – nata per difendere l’“ars gallica” dall’ingombrante vicino tedesco – presenta il suo Concerto per violoncello e orchestra. Un concerto che però, ironia della sorte, guarda proprio a un grande tedesco: Robert Schumann. Non solo per la tonalità di la minore, ma per la struttura compatta, in un unico grande movimento che contiene tre sezioni senza soluzione di continuità. Il materiale tematico si trasforma, ritorna, si reinventa: un omaggio, più o meno dichiarato, anche a un altro tedesco, Franz Liszt e alla sua forma ciclica. Tradizione e libertà, disciplina e piacere del colore convivono in una delle opere più rappresentative di Saint-Saëns, compositore che, come scrisse Romain Rolland, ebbe «la gloria di diventare, ancora vivente, un classico».
L’anima “lirica” del concerto emerge soprattutto nel trattamento della melodia del violoncello, modellata come una voce: rotonda, flessibile, capace di palpitare grazie a minime inflessioni espressive. Il bel canto non è mai lontano. Ettore Pagano, romano, ventidue anni, premio Abbiati 2025 e già tra i violoncellisti più richiesti della sua generazione, lo sa bene. La sua interpretazione unisce una musicalità naturale a una tecnica superlativa, restituendo l’equilibrio perfetto di una pagina fatta di rimandi interni, slanci vigorosi e improvvise zone d’ombra, di arie appena accennate e modulazioni felicissime. Solista e orchestra dialogano senza che uno prevalga sull’altra: virtù rara, oggi come ieri.
Gli applausi insistenti spingono Pagano a concedere due bis che spalancano finestre inattese sul presente. Prima Pēteris Vasks, poi Giovanni Sollima: dal suo prezioso Ongaro veneziano del 1777 emergono glissandi, colpi sulla cassa, pianissimi sospesi, echi di nenie orientali, improvvisi scatti rock. Il pubblico, inevitabilmente, si entusiasma.
La seconda parte del concerto ci porta nel Novecento, quello di Debussy e Stravinskij riletti da Ottorino Respighi nella sua trilogia romana di poemi sinfonici che avevamo ascoltato appena tre anni fa da Robert Treviño nella sua interezza. Questa volta, invece, Orozco-Estrada si limita ai primi due, quelli dedicati alle fontane e ai pini di Roma.
Nelle Fontane di Roma (1916), Respighi cerca l’immagine sonora pura, la suggestione: quattro quadri osservati nell’ora in cui la loro bellezza è più eloquente. Un mondo ormai scomparso, come quello pastorale della fontana di Valle Giulia, con mandrie all’alba e zampognari evocati da oboi e clarinetti. Qui la maestria strumentale del compositore è magistrale, con il gocciolio dell’acqua affidato agli archi e il sorgere del sole a un cambio di tonalità di intensa cantabilità.
Più teatrale l’atmosfera della fontana del Tritone al mattino con la danza sfrenata di naiade e tritoni, e quella della fontana di Trevi “al meriggio”, con il solenne passaggio del carro di Nettuno. L’ora nostalgica del tramonto è affidata alla fontana di Villa Medici, un brano che intreccia il “sommesso chioccolio” dell’acqua della fontana realizzato da arpa e celesta con un tema triste presentato dai flauti e dal corno inglese. Si fa poi sentire il rintocco di una campana che la partitura prescrive “molto lontana”. Bisbigli di uccelli e brusii di foglie si possono ascoltare nell’episodio successivo prima del finale che si spegne lentamente morendo in maniera estremamente suggestiva sulle note dei secondi violini.
Otto anni dopo arrivano i Pini di Roma. Nel frattempo il mondo è cambiato: la Grande Guerra, la Marcia su Roma, il delitto Matteotti. Alla prima del 14 dicembre 1924, al Teatro Augusteo, il fascismo è saldo al potere dopo le elezioni del 6 aprile vinte dal “listone” mussoliniano in un clima di intimidazioni e violenze squadriste. Anche in questo poema sinfonico contano le immagini, ma il tono è diverso e i quattro quadri sono radicalmente differenti. Si comincia col chiasso dei bambini che giocano a Villa Borghese, in una scena che ricorda il secondo atto della Bohème. A questo caleidoscopico sfolgorio segue il buio delle liturgiche melopee degli oranti nelle catacombe, mentre pallida è invece la luce del plenilunio al Gianicolo col canto di un autentico canto d’usignolo registrato su disco. Fino all’apoteosi dei legionari sulla via Appia. Un crescendo colossale, martellante, che Giorgio Pestelli giustamente aveva commentato così: «si esce un poco imbarazzati dal rimbombo di tanta grandiosità di cartapesta». Il “progetto balistico” in cui gong, timpani e ottoni fanno progressivamente salire la temperatura, pare fastidiosamente scontato. Ma il pubblico dell’Auditorium si lascia conquistare senza riserve e applaude con entusiasmo.
⸪