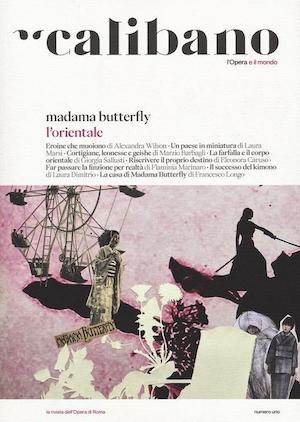•
Alberto Mattioli, Gran Teatro Italia
186 pagine, Garzanti Editore, 2023
Io ho talora dato scandalo affermando che entrare in un teatro mi dà un’emozione più intensa di quando entro in una chiesa. E non è solo il fatto che non sono un credente e di un edificio religioso mi interessa principalmente l’aspetto architettonico o quello artistico dei suoi arredi.
Entrando in un teatro sento palpabile il senso del mistero di quello che avverrà e niente mi dà maggiormente il senso della comunità umana di quanto lo faccia il pubblico accorso per condividere con me un’esperienza dove la finzione – dichiarata tale – diventa l’unica realtà possibile. Attraverso lo specchio come Alice quando entro nel posto più strano di tutti, dove la luce naturale è bandita e nel buio può succedere qualunque cosa. Soprattutto nel teatro in musica, dove invece di parlare si canta su uno sfondo orchestrale.
Qualcosa del genere lo deve provare anche Alberto Mattioli, l’autore di questo testo che ha come sottotitolo “Viaggio sentimentale nel paese del melodramma”. Il Grand Tour che ci propone è infatti quello dei luoghi in cui si celebra il melodramma in Italia, il paese in cui i teatri sono stati, e sono, qualcosa di più di un semplice luogo d’incontro: «se in passato fra palchi e gallerie si indugiava per farsi notare, e nei ridotti si discuteva di politica e si giocava d’azzardo, ancora oggi i teatri si confermano il fulcro della vita civile e culturale – oltre che musicale – di ogni città».
Per me le città italiane, soprattutto quelle piccole, sono indissolubilmente legate all’immagine del loro teatro lirico: Piacenza, Parma, Macerata, Novara, Ravenna… sono quello che sta intorno al Municipale, al Regio, allo Sferisterio, al Coccia, al Comunale… Ma anche quelle grandi non sarebbero le stesse se Venezia non avesse La Fenice, Napoli il San Carlo, Genova il Carlo Felice, Milano La Scala…
E dalla Scala inizia necessariamente il viaggio di Mattioli. Il teatro milanese, il “Tempio della lirica”, costituisce la Sinfonia iniziale della sua opera che prevede anche un Intermezzo dedicato ai teatri mini – quelli con meno di 100 posti come il Concordia di Monte Castello di Vibio (PG), il Cittadino di Noicattaro (BA), il Rustici di Monteleone di Orvieto, il Comunale di Penna San Giovanni (MC) o il Salvini di Pieve di Teco (IM) da me scoperto per caso un anno fa – e si conclude con un Finale dedicato al Teatro Greco di Siracusa in cui non si fa opera, d’accordo, ma si fa quello che è il suo diretto antecedente, ossia la tragedia classica e che l’estate scorsa ha visto al lavoro sulle sue pietre due registi che generalmente fanno l’opera, ossia Davide Livermore, con l’Agamennone di Eschilo, e Robert Carsen, con l’Edipo re di Sofocle.
Il viaggio sentimentale di Mattioli lungo la penisola si svolge a zig zag da Nord a Sud: dopo Milano e Torino l’Emilia Romagna, la regione più ricca di teatri ancora in funzione. Quindi Venezia e Verona, con il caso sui generis dell’Arena, Firenze, le Marche, un’altra regione ricca di splendidi teatri, Roma, Napoli, Palermo in Sicilia. Manca l’altra isola, la Sardegna, e il Lirico di Cagliari forse avrebbe meritato una menzione.
Ma quello di Mattioli non è un elenco di luoghi dello spettacolo. È un elenco dei luoghi del cuore, della sua passione “smodata” (il termine è suo) per quello che è stato, fino a non molto tempo, fa l’evento culturale più importante e diffuso nel nostro paese. Quello che fin dalle origini a inizio Seicento, poi per tutto il Settecento e per buona parte dell’Ottocento ha fatto conoscere l’Italia all’estero – e agli italiani – : l’opera di Monteverdi, Vivaldi, Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi. In ogni teatro l’autore rivive le passioni e le idiosincrasie che suscitano le differenti atmosfere. Ecco allora la Scala di Milano, Il primo teatro del mondo? Magari no, ma quello che in Italia maggiormente si identifica con la sua città e viceversa, con il suo rito della prima a Sant’Ambrogio che riesce a far parlare tutti, anche quelli che non vi hanno mai messo il piede dentro. Se passiamo alla capitale, l’Opera di Roma si rivela lo specchio dei vizi della sua città: «a irritarmi davvero fu il pubblico», scrive Mattioli, «non sembrava nemmeno di essere a teatro, anzi di starci, come si dice a Roma, semmai su qualche terrazza nei casi migliori o al mercato in quelli peggiori. Era tutta una chiacchiera, un arrivare in ritardo, un entrare e uscire dai palchetti sbattendone le porte». E poi gli abiti, con la sindaca Virgina Raggi presentatasi alla prima con «un incrocio tra la divisa di un ammiraglio sudamericano e i divani dei Casamonica». A Palermo ha invece una singolare vicenda con il green pass in tempo di Covid, una vicenda che conferma come «la Sicilia sia un’Italia all’ennesima potenza, dove le glorie e le miserie, le grandezze e le meschinità, i fasti e i disastri e insomma le contraddizioni nazionali vengono portate all’estremo, nel bene e nel male».
La pungente penna dell’autore non risparmia nessuno e nulla dell’ambiente dell’opera in Italia, ma ogni parola della sua brillante prosa trasuda l’incommensurabile amore per questa forma d’arte alla quale ha dedicato tanti suoi scritti e continua a dedicare molta parte della sua esistenza. Quello che esce fuori però non è un modello di teatro chiuso nel suo guscio autoreferenziale, ma un essere vivo e palpitante che si rinnova ogni giorno, con buona pace delle anime candide dei Melomani Medi che vorrebbero vedere sempre la stessa Bohème o Traviata. Possibilmente con le stesse voci di un tempo…
⸪