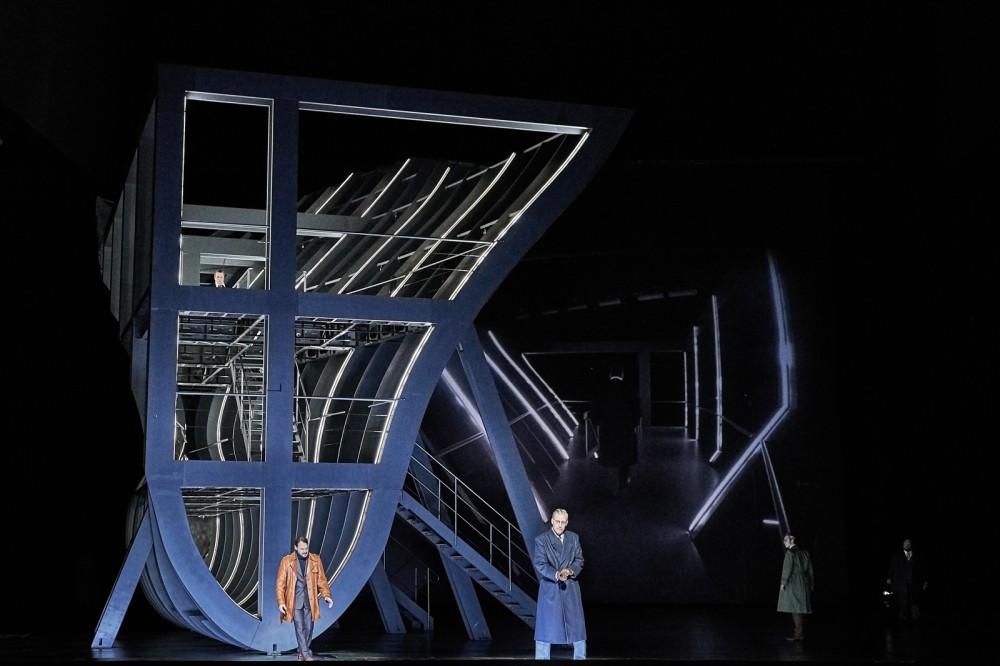★★★★☆
Pupi barocchi: opera veneziana e burattini siciliani
«Così va, così va» si lamenta la vecchia nutrice: quando si diventa anziani, l’amore «più nei cori non desta pietà».
È affidato a un personaggio secondario il momento più toccante di Caligula delirante, l’opera con cui il genovese Giovanni Maria Pagliardi debuttava a Venezia il 18 dicembre 1672 al Teatro San Giovanni e Paolo con grande successo. A questa sua prima opera ne seguiranno una decina, presentate per lo più a Firenze alla Villa di Pratolino essendo il compositore al servizio di Cosimo III de’ Medici dopo la morte del Cesti. Prima del debutto operistico nella sua città natale il Pagliardi si era distinto con lavori sacri tra cui l’oratorio L’innocenza trionfante.
Su libretto di autore incerto (si fanno i nomi di Nicolò Beregan o di Domenico Gisberti, il quale aveva scritto nel 1660 per Cavalli La Pazzia in trono ovvero Caligula delirante, rimasta incompiuta), la sua prima opera riprende il personaggio dell’imperatore folle e sanguinario narrato da Svetonio.
Una regina sconosciuta di grande bellezza, Teosena, è venuta a chiedere a Caligola aiuto dopo la morte in mare di suo marito, Tigrane, re di Mauritania. L’imperatore se ne innamora e ordina che facciano il ritratto della bella, suscitando la gelosa ira dell’imperatrice Cesonia e lo stupore dello schiavo-pittore, che altro non è che Tigrane travestito e sopravvissuto al naufragio. Ripudiata dal marito, che celebra apertamente il suo amore per la straniera, Cesonia ordina al fedele servitore Nesbo di uccidere la rivale e fa bere al marito una pozione magica. Nel frattempo, Tigrane, ancora travestito da pittore, cerca di farsi conoscere dalla moglie ma è in competizione con Artabano, Re dei Parti, il suo padrone e anche lui innamorato di Teosena. Bevuta la pozione, Caligola cade in preda della follia, respinge la moglie, caccia i suoi ospiti, corteggia la vecchia nutrice Gelsa, si crede prima Ercole all’inseguimento di Diana e poi un pastore innamorato della luna. Di fronte al suo folle atteggiamento, il Senato destituisce Caligola a favore di Claudio che blocca la partenza per l’esilio di Cesonia, mentre Tigrane, riconciliato con Teosena, cerca di affermare i suoi diritti contro il rivale Artabano, che non capisce come una regina gli preferisca uno schiavo. Alla fine Caligola, dato per morto dopo essersi ferito, ritrova il senno e riconosce sua moglie. Tutto rientra nell’ordine e Caligola aiuterà persino Tigrane a riprendersi il trono di Mauritania.
La vicenda rivive sulle tavole del teatrino di Charleville-Mézières (Ardennes) dove si svolge il Festival mondiale delle marionette nel settembre 2012. Lo spettacolo verrà ripreso con successo anche nella capitale francese e registrato in un blu-ray. È Vincent Dumestre, specialista di musica barocca e direttore dell’ensemble Poème harmonique, a ritrovare la partitura del lavoro del Pagliardi nella biblioteca Marciana di Venezia e a pensare a una realizzazione scenica utilizzando delle marionette, in particolare i pupi di Mimmo Cuticchio.
Sembra una scommessa audace aver voluto affidare a degli inerti burattini di legno il compito di esprimere la ricca gamma dei sentimenti (folle amore, cieca gelosia, ferocia, malinconia, amore coniugale) espressi in questa storia che non si fa mancare un quanto mai improbabile lieto fine. Eppure l’interazione fra pupi, pupari e cantanti riesce alla perfezione e conquista un pubblico smaliziato. Assieme ad Alexandre Rübner, Cuticchio ha concepito uno spettacolo illuminato da candele e con deliziosi fondali dipinti che ha la magia di un teatro ricreato nella sua poetica essenzialità.
Ridotta ai minimi termini, la partitura viene restituita da due violini per la melodia e da altri cinque strumentisti (lirone, viola da gamba, violone, liuto, tiorba, chitarra e clavicembalo) per l’armonia.
Sei ottimi cantanti prestano la loro voce agli interpeti di legno: Jan van Elsacker, (tenore, Caligola), Caroline Meng (soprano, Cesonia), Florian Götz (baritono, Artabano/Domizio), Jean-François Lombard (haute-contre, Tigrane/Claudio), Sophie Junker (soprano, Teosonia), Serge Gougioud (tenore, Nesbo/Gelsa).
⸪