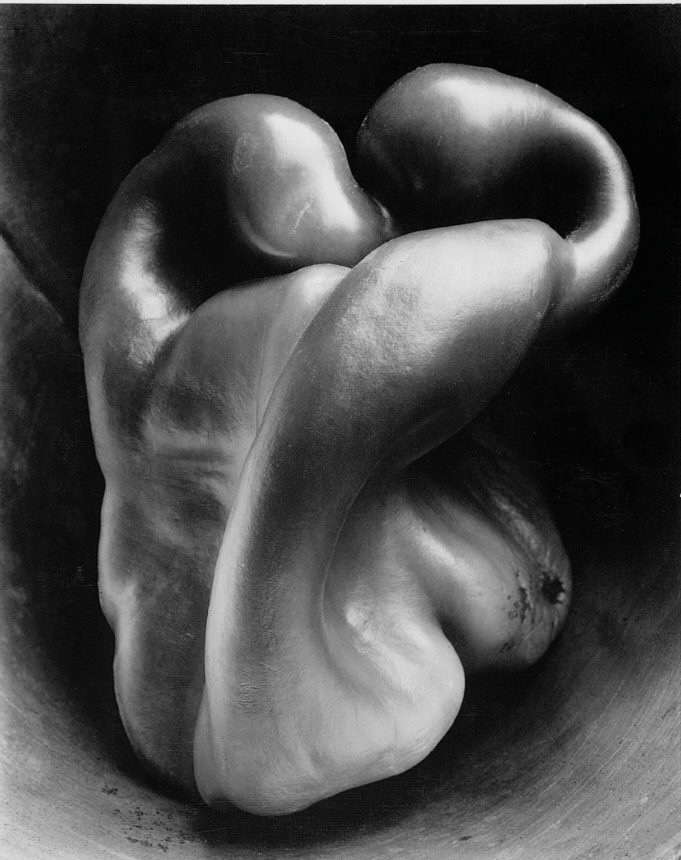•
Jean-Baptiste Lully, Le Carnaval
Ferrara, Teatro Comunale, 14 febbraio 2026
(video streaming)
Il Carnevale del Re Sole si mette a volare per il pubblico di oggi
La nuova produzione di Le Carnaval, Mascarade Royale di Lulli al Teatro Comunale di Ferrara restituisce lo spirito festivo del ballet de cour barocco con fantasia e invenzione visiva. La regia di Emiliano Pellisari, tra specchi e corpi sospesi, dialoga con la direzione vivace di Federico Maria Sardelli, trasformando la frammentarietà dell’opera in uno spettacolo poetico e sorprendentemente contemporaneo.
Ci sono spettacoli che si limitano a “rimettere in scena” un titolo antico, e altri che tentano qualcosa di più raro: restituire la sensazione stessa di un’epoca. Le Carnaval, Mascarade Royale di Giovanni Battista Lulli – fiorentino naturalizzato francese e architetto musicale della corte di Luigi XIV – appartiene decisamente alla seconda categoria. La nuova produzione presentata al Teatro Comunale di Ferrara lo dimostra con brillante evidenza: non un esercizio museale di filologia barocca, ma una festa teatrale piena di fantasia, ironia e meraviglia visiva.
Il punto di partenza è già di per sé intrigante. Nato nel 1668 alla corte del Re Sole come ballet de cour «pour divertir le plus grand roi du monde», è un curioso oggetto teatrale: una sorta di “antologia” di entrées, quadri indipendenti che mescolano episodi pastorali, caricature borghesi, parodie esotiche e maschere carnevalesche. Una struttura volutamente frammentaria, più vicina alla logica della festa che a quella del dramma. Su libretto multilingue (italiano, francese, spagnolo e una caricatura del turco) di Philippe Quinault, con testi anche di Molière (Monsieur de Pourceaugnac) e Isaac de Benserade, ne risulta un mosaico scenico che celebra il Carnevale come regno della metamorfosi, della maschera e dell’invenzione teatrale. Sette anni dopo venne ripreso, ampliato e destinato al pubblico dell’opera.
Dopo oltre tre secoli di oblio – è la prima rinascita moderna di un lavoro mai più rappresentato dopo il 1675 – Le Carnaval torna in scena grazie all’edizione critica curata da Bernardo Ticci e a un progetto che unisce ricerca musicologica e ambizione spettacolare. L’idea nasce da Marcello Corvino e prende forma in una coproduzione tra i teatri di Ferrara e Modena, ma il vero colpo d’occhio della serata arriva dalla regia di Emiliano Pellisari, che affronta il materiale barocco con un’intelligenza dichiaratamente anti-archeologica.
Pellisari non tenta di ricostruire il Seicento: lo evoca, lo reinventa, lo filtra attraverso un immaginario visivo fatto di illusioni sceniche, corpi sospesi e prospettive capovolte. Al centro della scena domina un grande specchio inclinato a 45 gradi che riflette i danzatori stesi sul palcoscenico e moltiplica le figure, creando l’impressione di corpi che sfuggono alla gravità e fluttuano nello spazio teatrale, volteggiando nel vuoto. Il risultato è un teatro dell’illusione degno delle macchine barocche, ma con una sensibilità decisamente contemporanea, grazie anche ai deliziosi costumi dall’aspetto settecentesco con cui Daniela Piazza veste i cantanti e i ballerini, questi ultimi caratterizzati da abiti immaginifici ed eterei. Il concept art è di Nora Bujdoso e il progetto luci, pensato da Pellisari in collaborazione con Gregory Zencher, modella con magia lo spazio.
Ed è proprio qui che la produzione trova la sua cifra più originale: la fusione fra musica barocca e linguaggio coreografico, quasi acrobatico. I danzatori della compagnia NoGravity Theatre, guidati dallo stesso Pellisari e da Mariana Porceddu, trasformano ogni entrée in una visione: figure che si riflettono, corpi che si inclinano e sembrano galleggiare nello spazio, tableaux che oscillano tra la pittura barocca e il sogno circense. Non è una danza che “illustra” la musica, ma un dispositivo visivo che amplifica il senso di meraviglia tipico del teatro di corte.
In fondo, il cuore dello spettacolo è proprio questo: ricreare la logica spettacolare della Versailles di Luigi XIV, dove la musica non era mai sola, ma sempre intrecciata con danza, scenografia e celebrazione politica. Il balletto di corte era uno strumento di rappresentazione del potere, e Lulli, ballerino egli stesso, ne fu il grande regista sonoro. Il suo Carnaval non racconta una storia: costruisce un mondo festivo dove ogni scena è un piccolo rituale teatrale.
Sul piano musicale, la guida di Federico Maria Sardelli rappresenta una garanzia assoluta. Il direttore livornese – tra i massimi specialisti del repertorio barocco – conduce la sua Orchestra Barocca Modo Antiquo con energia teatrale e raffinato senso del colore. La partitura di Lulli, che alterna pagine pompose a momenti di lirismo quasi sospeso, trova così una lettura vivace, elastica e ricca di sfumature. Sardelli non cade mai nella tentazione del barocco “museale”: la sua direzione respira con il palcoscenico e sostiene con attenzione il gioco scenico e coreografico.
Accanto all’orchestra, il Coro I Musici del Gran Principe, preparato da Samuele Lastrucci, contribuisce con precisione e compattezza alle sezioni corali, mentre il cast vocale si muove con naturalezza tra canto e teatro: il soprano Valeria La Grotta, dal timbro luminoso e morbido, particolarmente efficace nell’aria «Di rigori armato il seno»; il mezzosoprano Giuseppina Bridelli offre una presenza scenica elegante e una vocalità calda; le voci tenorili di Philippe Talbot e Cyril Auvity uniscono tecnica sicura e gusto teatrale. Completano il quadro le voci più scure di Biagio Pizzuti e Alexandre Baldo, che danno sostanza agli interventi bassi della partitura.
Naturalmente, la struttura episodica dell’opera resta quella che è: un “pasticcio” barocco nel senso più gastronomico del termine, dove convivono ingredienti diversi, dalle caricature della commedia di Molière alle pastorali arcadiche, fino alle parodie esotiche – celebre la Marche pour la cérémonie des Turcs proveniente dal Bourgeois gentilhomme. Ma proprio questa eterogeneità diventa la chiave del divertimento. Lo spettatore non segue una trama: attraversa una successione di visioni, come in un grande corteo carnevalesco.
E forse è proprio qui che lo spettacolo centra il bersaglio. Il rischio di un titolo come Le Carnaval è quello di apparire drammaturgicamente fragile agli occhi moderni. Pellisari e Sardelli aggirano il problema con una soluzione semplice: trasformare la frammentarietà in principio estetico. Non un racconto lineare, ma una sequenza di apparizioni.
C’è anche qualcosa di simbolico in questa riscoperta. Lulli, fiorentino trapiantato a Parigi e diventato Jean-Baptiste Lully, è stato uno dei grandi inventori del teatro musicale europeo. Eppure, fuori dagli ambienti specialistici, resta un nome meno frequentato rispetto ai suoi successori. Riportare in scena Le Carnaval significa dunque non solo recuperare un titolo raro, ma riaprire una finestra su un momento fondamentale della storia dello spettacolo.
E se il teatro barocco era, prima di tutto, un’arte della meraviglia, questa produzione lo dimostra con eloquenza. Tra specchi inclinati, danze sospese e fanfare luminose, il Carnevale del Re Sole torna a vivere – leggero, ironico e sorprendentemente contemporaneo. In fondo, il segreto di questa serata sta tutto qui: farci credere, per un’ora e mezza, che il teatro possa ancora essere una macchina di sogni. E, come accadeva a Versailles, uscirne con la sensazione che la festa non sia mai davvero finita.
Dopo Ferrara Le Carnaval approderà prima a Modena e poi a Firenze, qui però soltanto in forma concertistica.
⸪