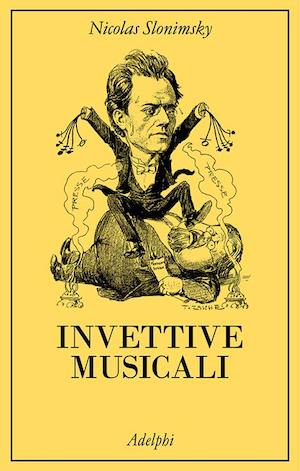foto © Fabrizio Sansoni
∙
Georg Friedrich Händel, La Resurrezione
Roma, Basilica di Massenzio, 4 luglio 2025
★★☆☆☆
 ici la version française sur premiereloge-opera.com
ici la version française sur premiereloge-opera.com
Quando il diavolo veste in lamé
Il Festival di Caracalla 2025, curato da Damiano Michieletto e intitolato Tra sacro e umano, si apre con La Resurrezione di Händel. L’oratorio, eseguito dalla Orchestra Nazionale Barocca dei Conservatori diretta da George Petrou, convince solo nelle voci femminili. La regia di Ilaria Lanzino, attualizzata in chiave familiare e borghese, risulta confusa, di gusto discutibile e accolta con freddezza.
“Tra sacro e umano”, così si intitola il festival estivo di Caracalla 2025, un cartellone ricco e multidisciplinare, curato da Damiano Michieletto, che si snoda tra opera (Traviata, Don Giovanni), musica sacra (La Resurrezione), musical (West Side Story), danza e concerti pop.
Dà il via l’oratorio sacro che il giovane Händel scrisse durante il suo viaggio in Italia nel 1708 a Roma ospite della famiglia Ruspoli: una commissione di papa Clemente XI impegnato nella guerra di successione spagnola. Stupisce la decisione di incaricare un luterano come Händel per un oratorio pasquale di argomento così cattolico, ma probabilmente la scelta faceva parte di una meditata strategia tesa a celebrare la “resurrezione” della chiesa cattolica contro i nemici protestanti, oltre ovviamente alla grande fama del Sassone.

L’8 e 9 aprile di quell’anno viene dunque eseguito a Palazzo Bonelli (oggi Valentini) di piazza Santi Apostoli uno dei più costosi e spettacolari oratori che si fossero visti allora a Roma: «l’Oratorio per la Risurrettione di Nostro Signor Giesù Cristo su poesia del Sig. Carlo Sigismondo Capece e musica del Sig. Giorgio Federico Hendel», come si legge sul libretto stampato in ben 1500 copie. L’impresa frutterà al marchese Ruspoli il titolo di principe di Cerveteri l’anno successivo. Il teatro ligneo allestito al piano nobile del palazzo prevedeva quattro gradinate per l’orchestra e un podio per il concertino degli archi diretto da Arcangelo Corelli. Gli strumentisti erano parzialmente celati alla vista del pubblico da una tavola riccamente decorata con cornucopie e da una grande tela di 12 metri quadrati dipinta da Michelangelo Ceruti raffigurante la resurrezione di Cristo in un tripudio di putti e cherubini, l’angelo seduto sul sepolcro per l’annunciazione alla Maddalena, e ancora Maria di Cleofa e Giovanni Battista. Sullo sfondo demoni che sprofondano nell’abisso. Sono i personaggi che troviamo nei 23 numeri (tra cui due duetti e due cori) ripartiti in due parti e otto scene. (1)
Sulla tela era intagliato il titolo dell’oratorio con lettere alte 18 cm retroilluminate da candele sorvegliate da due uomini di guardia. L’orchestra era composta da 36 archi, due trombe, un trombone, due oboi, flauto e fagotto. La parte di Maria Maddalena era sostenuta da Margherita Durastanti nonostante il divieto papale di far cantare donne sulle scene pubbliche, infatti dopo le due esecuzioni private, nelle repliche pubbliche fu sostituita da un evirato cantore. Una delle arie di Maddalena è la frivola «Ho un non so che nel core», che conclude la seconda scena della prima parte e che la Durastanti canterà l’anno successivo a Venezia nella profanissima Agrippina, uno dei tanti esempi di disinvolti autoimprestiti comuni all’epoca.

Ora, sotto la maestosa volta a botte dei ruderi della basilica di Massenzio, ma con il rumore del traffico romano e i garriti dei gabbiani sopra il Colosseo e i Fori Imperiali, la musica della volenterosa Orchestra Nazionale Barocca dei Conservatori – progetto sostenuto dal Ministero dell’Università e della ricerca in collaborazione con Conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo – viene amplificata in modo tale da appiattire i suoni così che diventa difficile giudicare la resa strumentale (che non sembra eccelsa, comunque) e la direzione di George Petrou, frequentatore assiduo del repertorio händeliano, asciutta e precisa, in cui si nota però un certo allargamento dei tempi che si riflette sulla fatica dei cantanti, soprattutto maschili: un Charles Workman (Giovanni) sempre grandissimo stilista ma troppo sobrio e un Giorgio Caoduro in difficoltà con l’impegnativo ruolo di Lucifero. Alla fine della rappresentazione saranno gli interpreti meno applauditi.

Lodi incondizionate invece per le voci femminili. Sara Blanch è un angelo dalla voce cristallina e sicura tecnica che svetta nelle agilità della iniziale «Disserratevi, o porte d’Averno» o nella successiva «Risorga il mondo, lieto e giocondo col suo Signor» fino alla drammatica «Se per colpa di donna infelice». Ana Maria Labin (Maddalena) si esprime invece in un registro più introspettivo e doloroso, con una linea di canto attenta alla bellezza del suono. Perfetta la Cleofe di Teresa Iervolino, anche lei impegnata negli sbalzi e nelle puntature di «Naufragando va per l’onde», l’immancabile aria dove la metafora della tempesta di mare riflette i tumulti dell’anima umana. Prima aveva offerto un grandioso esempio di espressività emotiva unita a perfetta tecnica vocale con l’intensa «Piangete, sì piangete».
È la grande eterogeneità dei numeri musicali dell’oratorio a crearne la drammaturgia senza scene, ma ultimamente molti pezzi sacri vengono presentati con un’ambientazione e una drammaturgia che spesso aggiungono un qualcosa di più alla fruizione del lavoro: è il caso del Saul allestito da Kosky a Glyndebourne nel 2015 o da Guth a Vienna nel 2021. Per non parlare del recente Stabat Mater di Castellucci a Ginevra. Ci prova anche Ilaria Lanzino, pisana attiva all’estero come regista, in Polonia ma soprattutto in Germania, la patria del Regietheater, dove ha fatto diventare Lucia di Lammermoor un uomo.
Ora debutta in Italia con questa sua lettura dell’oratorio händeliano come racconto di una famiglia contemporanea in lutto per la perdita del figlio. Il solenne tema sacro viene quindi svolto nell’intimità borghese di una coppia devastata dal dolore, ma fin dall’inizio si evidenziano problemi con la sua drammaturgia: come è prassi comune il lavoro di Händel è introdotto da una Sinfonia tripartita nei movimenti Allegro-Lento-Allegro, ed è appunto sul tema allegro iniziale che entra in scena un mesto corteo funebre con la piccola bara bianca del morticino. Un effetto decisamente straniante. Ma è il secondo allegro che dà il tono della sua ambientazione, allorché entra in scena un gruppo di cheerleader d’entrambi i generi capeggiato da un angelo dalle ali spelacchiate che dopo aver intonato la sua prima aria se la deve vedere con Lucifero che si era camuffato nel gruppo, ma che ora, smascherato, si ripara dietro le quinte per poi riapparire indossando il suo vero abito: se il diavolo veste Prada, qui porta un lungo abito nero da sera con paillettes, parrucca e trucco pesante. Insomma, ci dice la regista, il travestimento da drag queen è diabolico e il male sta nella commistione dei generi. I partecipanti dei Pride ringraziano…
Sulle note del sacro oratorio assisteremo poi al tableau vivant con fermo immagine del piccolo portato inutilmente in ospedale dove è presente, chissà perché, un clown. In seguito vedremo il dramma della madre (Maddalena) prima in crisi religiosa, poi consolarsi con l’alcol e quindi venire poco cristianamente cacciata di casa dal marito (Giovanni) che si consola con un’altra sposa, già incinta però, con la quale convola a nuove nozze. O era un flashback del primo matrimonio? Chissà. Nel finale arriva dalla platea un bambino, biondo ovviamente, che si porta via la mamma n° 1 mentre quella n° 2 col neonato in braccio, assieme alla nonna Cleofe, Lucifero, il clown e altri personaggi intonano il coro finale «Diasi lode in cielo e in terra».

Se con questo suo spettacolo Lanzino voleva aprirsi la strada verso i teatri italiani non so se ci è riuscita. Lo spettacolo è sì tecnicamente ben costruito, ma per nulla pertinente e zeppo di momenti che non sono atti di irriverenza ma semplice e gratuita caduta di gusto. Nella scenografia di Dirk Becker la solita piattaforma rotante illustra i vari ambienti realisticamente definiti: l’altare della chiesa; la stanzetta del bambino con i suoi peluche; la camera da letto dei genitori dove il marito cerca di consolare sessualmente la moglie mentre lei gorgheggia «Ho un non so che nel core», scambiando la visione mistica di Maddalena con i mugolii di un orgasmo…
I costumi di Annette Braun e le luci di Marco Filibeck completano visivamente una lettura che secondo la regista si ispira al cinema d’autore: Antichrist di Lars von Trier; La stanza del figlio di Nanni Moretti; The Broken Circle Breakdown di Felix van Groeningen; So Long, My Son di Wang Xiaoshuai. Tanta roba per uno spettacolo infelice accolto piuttosto freddamente dal pubblico che ha risposto con applausi da minimo sindacale al termine di questa terza replica. Stasera l’ultima.
(1) Parte I. Scena 1 – In un dialogo fra l’Angelo e Lucifero, quest’ultimo domanda da dove venga tanta luce e il motivo di quell’insolita visita. La creatura celeste risponde annunciando la venuta del Re. Il signore degli abissi, cacciato un tempo dal Paradiso, crede ora di aver avuto la sua rivincita poiché in quel giorno il Figlio di Dio è stato sconfitto dalla morte. L’Angelo gli impone di tacere; infatti egli non comprende che Dio ha scelto di soffrire la Passione per amore e che con il suo gesto ha riscattato l’umanità e vinto la morte. Scena 2 – Maddalena e Cleofe si dolgono della morte di Gesù, quindi giunge Giovanni a consolarle e infondere in loro la speranza giacché il terzo giorno, quello della Resurrezione, è prossimo. Maddalena e Cleofe si recano presso il sepolcro di Cristo con balsami e unguenti, mentre Giovanni si reca a confortare la Vergine Maria. Scena 3 – L’Angelo invita le anime dei morti a uscire dal tetro luogo ove per lungo tempo hanno atteso il momento di seguire Cristo nel giorno del trionfo della vita.
Parte II. Scena 1 – Rimasto solo, Giovanni racconta le lacrime versate dalla terra e la speranza di veder risorgere il Dio vincitore. Scena 2 – L’Angelo intona una lode alla Resurrezione del Signore e del mondo che egli ha salvato. All’udire quelle parole, Lucifero è mosso a vendetta e proclama la sua intenzione di confondere gli animi umani e impedire alle pie donne di diffondere la notizia che Cristo è risorto. Scena 3 – Maddalena e Cleofe, giunte al Sepolcro, rammentano che Gesù non ebbe timore di affrontare la morte per loro. Scena 4 – Cleofe ha l’impressione che il cielo si stia rasserenando, poi nota che la tomba è aperta e che un giovane è assiso a destra. Maddalena esorta l’amica ad avvicinarsi alla misteriosa creatura da cui sente promanare un senso di consolazione. L’Angelo annuncia alle donne che Gesù non è più nella tomba, ma è risorto dai morti e che il felice messaggio deve essere riferito a tutti. Colme di gioia, esse cantano lodi e vanno cercando il Signore. Scena 5 – Cleofe si imbatte in Giovanni che le domanda dove sia diretta ed ella lo informa della notizia e del modo in cui le è stata rivelata. Poco dopo i due vengono raggiunti da Maddalena, che narra loro come abbia visto il Signore e gli sia corsa incontro per baciargli le piaghe, ma egli le abbia detto di non poter essere toccato e sia scomparso. A quelle parole Giovanni comprende che il tempo del dubbio è finito, Gesù è risorto e con lui il mondo è salvo. Il coro invita a lodare Dio in cielo come in terra.

⸪