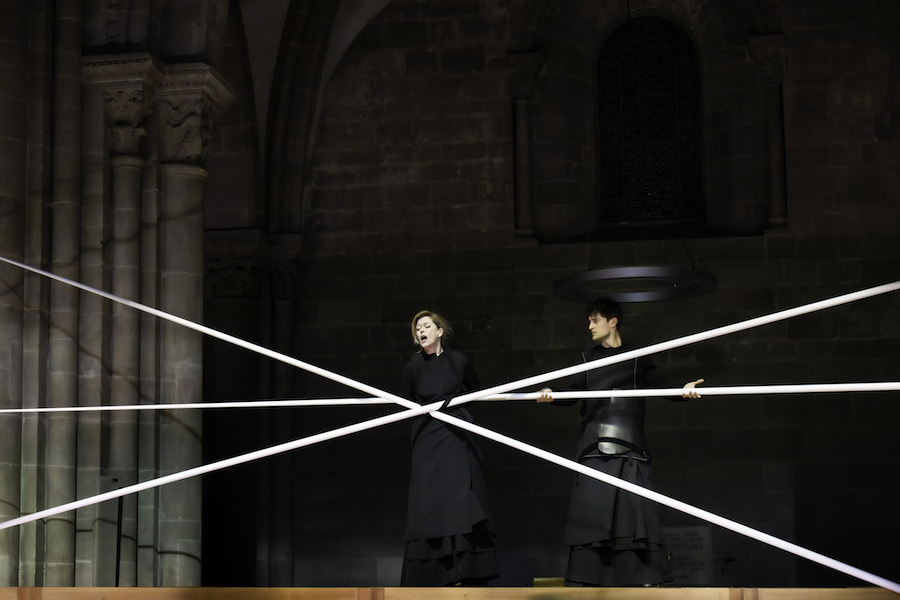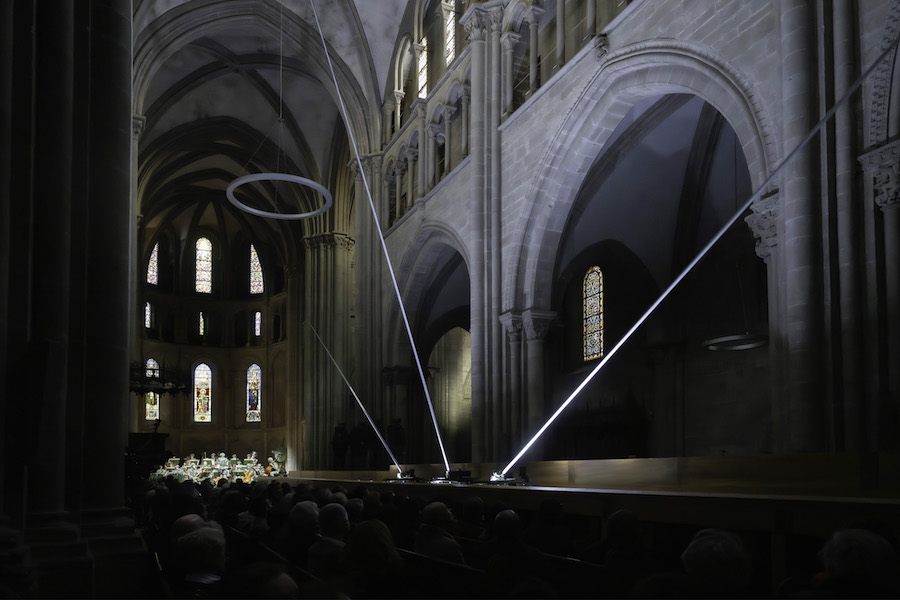∙
Gustav Mahler, “Lieder und Gesänge aus der Jugendzeit”, 1. Frühlingsmorgen; George Butterworth, “Six Songs from a Shropshire Lad”, I. Loveliest of Trees; Gustav Mahler, “Rückert-Lieder”, II. Ich atmet’ einen Linden Duft; George Butterworth, “Six Songs from a Shropshire Lad”, II. When I was one-and-twenty; Gustav Mahler; “Rückert-Lieder”; I. Blicke mir nicht in die Lieder!; George Butterworth, “Six Songs from a Shropshire Lad”, III. Look not in my eyes; Gustav Mahler, “Rückert-Lieder”, V. Liebst du um Schönheit; George Butterworth, “Six Songs from a Shropshire Lad”, IV. Think no more, Lad; Gustav Mahler, “Rückert-Lieder”, IV. Um Mitternacht; George Butterworth, “Six Songs from a Shropshire Lad”, V. The Lads in their hundreds; Gustav Mahler, “Rückert-Lieder”, III. Ich bin der Welt abhanden gekommen; George Butterworth, “Six Songs from a Shropshire Lad”, VI. Is my team ploughing?; Gustav Mahler, “Des Knaben Wunderhorn”, Revelge
Gustav Mahler, “Des Knaben Wunderhorn”, Aus! Aus!; Erich Wolfgang Korngold, “Zwölf Lieder ‘So Gott und Papa will'”, VI. Aussicht; Alma Mahler, Fünf Lieder, V. Ich wandle unter Blumen; Erich Wolfgang Korngold, Der Knabe und das Veilchen; Alma Mahler, “Fünf Lieder”, III. Laue Sommernacht; Erich Wolfgang Korngold, “Sechs einfache Lieder”, IV. Liebesbriefchen; Alma Mahler, “Fünf Lieder”, IV. Bei dir ist es traut; Gustav Mahler, “Des Knaben Wunderhorn”, Nicht wiedersehen; Anonimo, Terezin Song; Ilse Weber, Ade Kamerad; Adolf Strauss, Ich weiß bestimmt, ich werd’ dich wiedersehen; Ilse Weber, Ich wandre durch Theresienstadt; Ilse Weber, Wiegala; Gustav Mahler, “Des Knaben Wunderhorn”, Urlicht
Benjamin Appl baritono, James Baillieu pianoforte
Ginevra, Grand Théâtre, 15 maggio 2025
 ici la version française sur premiereloge-opera.com
ici la version française sur premiereloge-opera.com
Gustav Mahler & Co.
La stagione del Grand Théâtre di Ginevra comprende anche quattro recital di celebrati cantanti del momento: i soprani Lisette Oropesa e Aušrinė Stundytė, il controtenore Jakub Józef Orliński e il baritono Benjamin Appl.
Dopo gli esordi come giovane corista tra i Regensburger Domspatzen e specialista della musica di Bach, Appl è apprezzato in un vasto repertorio che spazia da Telemann a Luciano Berio, da Schubert a György Kurtág. Oltre all’attività concertistica, il cantante è frequentemente chiamato a interpretare musica oratoriale – oltre a Bach, Brahms, Haydn, Britten… – e personaggi d’opera, da Papageno nello Zauberflöte ad Arlecchino nella Ariadne auf Naxos. Appl ritorna a Ginevra per la terza volta dopo una Winterreise nel 2019 e una sostituzione improvvisa di Sir Simon Keenlyside nel 2023. Nel concerto odierno a Gustav Mahler affianca altri compositori della sua epoca.
Nella prima parte della serata, infatti, a Lieder tratti da diverse raccolte mahleriane si alternano songs di George Butterworth (1885-1916), compositore londinese collezionista di canti popolari e danzatore folk. Tra il 1911 e il 1912 Butterworth mise in musica undici poesie tratte da A Shropshire Lad di A. E. Housman, così come aveva anche fatto pochi anni prima Ralph Vaughan Williams. Ognuna dei sei songs qui scelti risponde idealmente a un titolo mahleriano: così al Frühlingsmorgen, della raccolta “Lieder und Gesänge aus der Jugendzeit” su testi di Richard Leander, segue Loveliest of Trees nella esaltazione della stagione primaverile e della gioventù. Qui al tiglio i cui rami battono alla finestra in Mahler, risponde il ciliegio fiorito di Butterworth. Lo stesso tiglio lo troviamo in Ich atmet’ einen Linden Duft dei “Rückert-Lieder” che ha la sua controparte in When I Was One-and-Twenty. E così via, con il gioco di sguardi del Blicke mir nicht in die Lieder e Look not in My Eyes, quello amoroso di Liebst du um Schöhnheit e Think no more, Lad.
Con Um Mitternacht, contrapposto a The Lads in Their Hundreds, si evidenzia però la diversa statura dei due compositori: alle insondabili profondità del notturno canto mahleriano si contrappone la musicalmente semplice ballata di Butterworth dove ragazzi arrivano alla fiera di Ludlow prima di partire per la guerra «dove moriranno nella gloria e non diventeranno mai vecchi». Lo stesso avviene nel successivo Ich bin der Welt abhanden gekommen, sempre di Friedrich Rückert, dove lo straziante addio alla vita, appena consolato dal fatto di sopravvivere nell’amore e nel canto, ha la sua controparte nel più prosaico Is my team ploughing? dove l’amata si consola col migliore amico del fidanzato morto. Conclude la prima parte della serata Revelge, una musica beffarda che avrebbe potuto scrivere Kurt Weill, che però doveva ancora nascere all’epoca della composizione del ciclo de “Il corno magico del fanciullo”… Qui Benjamin Appl dimostra il temperamento che fino a quel momento non era stato così evidente: il baritono tedesco è un grande liederista, ma le sue interpretazioni, perfettamente intonate con fraseggio impeccabile, non commuovono, anche a causa di un timbro chiaro che manca di armonici nel registro basso, armonici di cui era ricca invece la voce di Dietrich Fischer Dieskau di cui Appl è stato allievo e a cui dedicherà il secondo bis, lo schubertiano Du holde Kunst. In Revelge esce finalmente il temperamento del cantante, che qui sfoggia una certa libertà ritmica e un’espressività che prima erano mancate. Anche l’accompagnamento pianistico di James Baillieu, pur correttissimo, è risultato un po’ freddo e ha fatto rimpiangere l’orchestrazione adottata poi da Mahler.
Molto meglio riesce la seconda parte del concerto. Dopo l’intervallo, i pezzi scelti sono di contemporanei di Mahler o di compositori che hanno trovato la morte nei campi di concentramento o sono fuggiti dal Nazismo, come Erich Wolfgang Korngold, di cui si ascoltano tre deliziosi lavori: Aussicht, dal ciclo op.5, un gioioso inno alla bellezza della vita; Der Knabe und das Veilchen, duetto tra un ragazzo e una violetta, pezzo dall’ineffabile tono di operetta, e Liebesbriefschen dall’op.6. Anche Alma Mahler fornisce il suo contributo a questa svagata sequenza di tenere e sognanti miniature introspettive con Ich wandle unter Blumen (su testo di Heinrich Heine), Laue Sommernacht (Gustav Falke), in cui si canta delle notti d’estate, e Bei dir ist es traut (Rainer Maria Rilke). Il tutto è incorniciato da due brani da “Des Knaben Wunderhorn” di Gustav, Aus! Aus! e Nicht wiedersen, che inneggiano all’amore che però finirà: «Im Mai blühn gar viel Blümelein! | Die Lieb ist noch nicht aus! Aus! Aus!» (A maggio i fiori nascono in quantità! L’amore non è ancora finito! Finito! Finito!). Con il suo tono un po’ salottiero in questi pezzi Appl dimostra l’eleganza del suo porgere con delicate sfumature espressive.
Ma è con la terza e ultima parte che si scende nell’oscurità di sentimenti dolorosi. Il cambiamento di tono è quasi inavvertibile, poiché nell’anonimo Terezin Song il ritmo allegro cela la tragedia che si consuma nella città fortezza di Terezín, 60 chilometri a nord di Praga, dove venivano internati i maggiori artisti ebraici. Esibito dalla propaganda nazista come insediamento esemplare, ghetto modello, in realtà era un campo di raccolta di intellettuali, pittori, scrittori, musicisti ebrei – e di tantissimi bambini – in attesa di essere smistati nei campi di sterminio di Treblinka e Auschwitz. Qui si faceva musica, si allestivano spettacoli teatrali e conferenze e di qui passarono anche Adolf Strauss e Ilse Weber. Di quest’ultima, infermiera e poetessa morta ad Auschwitz, si ascoltano tre brani che si distinguono per la loro semplicità e forza. Ade Kamerad è l’addio a un compagno che non vedrà mai più: l’indomani verrò portata via col “trasporto polacco”. In Ich wandre durch Theresienstadt la donna si arresta ai bastioni della fortezza e guarda con sgomento e nostalgia il mondo di fuori. Wiegala è una straziante ninna nanna dalla disarmante tenerezza cantata poco prima della morte: «Es stört kein Laut die süße Ruh, | schlaf, mein Kindchen, schlaf auch du. | Wiegala, wiegala, wille, | wie ist die Welt so Stille!» (Nessun rumore turbi il tuo sonno, dormi mio piccolino, dormi. Ninna nanna, ninna nanna, com’è silenzioso il mondo!).
Musicista attivo nel ghetto di Praga, Adolf Strauss fu deportato a Terezín prima di finire anche lui nelle camere a gas di Auschwitz. Appl presenta un suo lavoro che ha inciso sull’album “Heimat” del 2017 e che anche Anne Sofie von Otter aveva registrato dieci anni prima: Ich weiss bestimmt, ich werd dich wiedersehen (Sono certo che ci rivedremo) riporta un po’ di speranza dopo tanto dolore. Sulla stessa linea è il pezzo finale del recital, Urlicht, ancora dal “Corno magico del fanciullo”, dove un angelo viene a consolare con la sua luce «l’uomo prostrato nella più grande miseria, nel più grande dolore».
Con compostezza e impeccabili mezzi vocali ed espressivi Benjamin Appl ha traghettato il pubblico attraverso questi abissi dell’anima. Agli insistenti applausi risponde con due bis. Prima della dedica a Fischer Dieskau di cui s’è detto, il baritono tedesco omaggia la sua nuova patria di adozione, la Gran Bretagna, con una canzone del 1936 molto popolare durante la Seconda Guerra Mondiale e che diede anche il titolo a un film del ’43, I’ll walk beside you, interpretata da Appl in modo tale da rivelare il suo amore per questo repertorio.
⸪