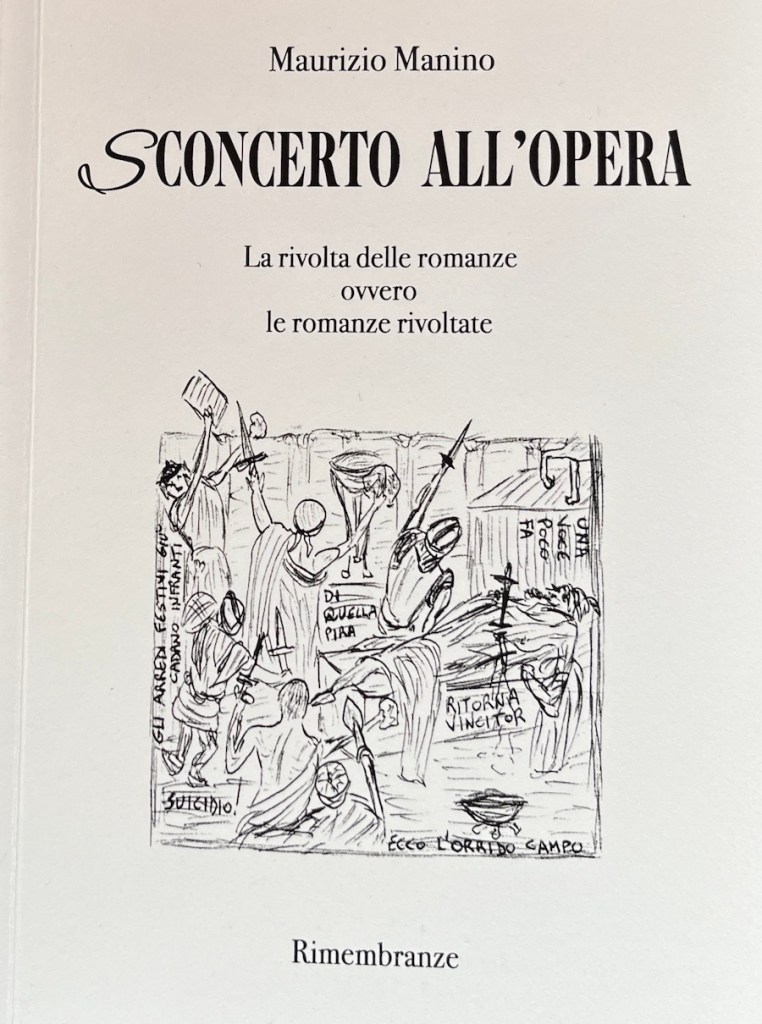foto © Vito Lorusso
•
Pietro Antonio Cesti, L’Orontea
Milano, Teatro alla Scala, 5 ottobre 2024
(diretta streaming LaScalaTv)
Una moderna commedia di quasi 370 anni fa
Anche i teatri italiani incominciano a interessarsi all’opera barocca. Alla Scala negli ultimi anni è stato messo in scena con ritmo biennale un titolo di quel repertorio: il Tamerlano di Händel nel 2017, il Giulio Cesare in Egitto ancora di Händel nel 2019, La Calisto di Cavalli nel 2021, Li zite ‘ngalera di Vinci nel 2023.
Ora il ritmo sembra intensificarsi, se nel 2024 si può assistere alla Orontea di Pietro Antonio Cesti, tra i più celebrati compositori della sua epoca. Nato nel 1623 ad Arezzo col nome di Pietro, vi aggiunse quello di Antonio quando entrò quattordicenne nell’ordine francescano. Corista e poi anche cantante solista – fu Egeo nella prima de Il Giasone di Cavalli – si dedicò alla composizione debuttando con Alessandro vincitor di sé stesso a Venezia nel 1651. L’anno successivo è a Innsbruck al servizio dell’arciduca Ferdinando Carlo dove vede la messa in scena de L’Argia (1655), L’Orontea (1656), La Dori (1657), La magnanimità d’Alessandro (1662). Nel 1665 è invece a Vienna quale maestro di cappella alla corte di Leopoldo I d’Asburgo e qui verrà messo in scena Il Pomo d’oro, il suo lavoro più famoso, per celebrare il matrimonio dell’imperatore. Morirà 46enne di passaggio a Firenze, forse per un avvelenamento.

Opera tra le più allestite nel Seicento, L’Orontea in tempi moderni ha avuto una pregevole produzione all’Opera di Francoforte nel 2015 con la regia di Walter Sutcliffe. Alla Piccola Scala si vide nel 1961 con Teresa Berganza protagonista e Bruno Bartoletti sul podio, mentre ora è Robert Carsen a mettere in scena queste vicende di amori, gelosie, travestimenti, equivoci, colpi di scena e agnizioni sapidamente trattati dai librettisti Giacinto Andrea Cicognini e Giovanni Filippo Apolloni .
Prologo. La filosofia e l’amore discutono su chi abbia più potere sull’uomo.
Atto primo. La regina Orontea rinuncia all’amore, nonostante il suo consigliere Creonte la esorti a sposarsi per il bene del regno. Il giovane pittore Alidoro arriva a corte cercando rifugio dai briganti insieme alla presunta madre Aristea. Spiega di essere dovuto fuggire dalla corte della regina Arnea di Fenicia. Nonostante il voto, Orontea si innamora di Alidoro, così come la cortigiana Silandra.
Atto secondo. Giacinta, travestita da ragazzo (Ismero), arriva alla corte di Orontea e spiega che c’è lei dietro l’agguato ad Alidoro, mandata ad ucciderlo dalla regina di Fenicia. Orontea si trattiene a stento dall’uccidere Giacinta con una spada. Creonte intuisce che la regina è innamorata di Alidoro e la rimprovera di aver scelto un plebeo. Aristea si innamora di Ismero. Nel frattempo, Alidoro dipinge un ritratto di Silandra. Orontea, pazza di gelosia, irrompe durante la seduta e Alidoro sviene. Orontea di pente e lascia ad Alidoro una corona e una lettera in cui confessa il suo amore.
Atto terzo. Creonte costringe Orontea a respingere Alidoro il quale viene scoperto in possesso di un medaglione reale e accusato di furto. Aristea spiega la provenienza del ioiello che dimostra che Alidoro non è altro che Floridano, il figlio da tempo perduto del re di Fenicia. Da bambino era stato rapito da una banda di pirati guidata dal marito di Aristea e allevato da lei come un figlio e ora è libero di sposare Orontea, così come Corindo Silandra.

Eliminato il Prologo, L’Orontea diventa un’opera di Carsen più che di Cesti, ma probabilmente non si poteva fare altrimenti. Si perde di vista il tema della lotta tra il dovere e il piacere e si dimostra la supremazia della passione sulla ragione, e dell’apparenza sulla sostanza, questo sì un aspetto molto contemporaneo esemplificato dalla superficialità della società rappresentata. Nella lettura del regista canadese l’improbabile regina d’Egitto Orontea è la proprietaria di una galleria d’arte nella Milano d’oggi – lo skyline dei grattacieli di piazza Gae Aulenti e del Bosco Verticale oltre la vetrata del suo ufficio non lascia adito a dubbi – una donna che ha giurato di non amare, ma se Turandot taglia loro la testa, Orontea si limita a declinare le offerte dei suoi nobili pretendenti. Per invaghirsi però in modo subitaneo di un pittore, squattrinato, male in arnese e pure ferito, che capita a corte, pardon alla galleria, mentre si sta allestendo una mostra. Inutile dirlo, la mostra successiva sarà dedicata alle opere del vagabondo e futuro sposo della signora, dipinti in cui ritrae sé stesso e famosi nudi femminili della storia dell’arte, richiamo neanche tanto sottile al suo ego strabordante e alla sua vocazione di seduttore.

Nella scenografia di Gideon Davy i vari ambienti ci vengono mostrati al ruotare di una struttura: ecco quindi il succitato ufficio con vista, lo spazio su due piani della galleria, il deposito delle opere e dei libri, il cortile con bidoni della spazzatura e moto parcheggiate. Lo stesso Davy firma i costumi, compreso il completo un po’ cafonal in nero e oro di Alidoro/Floridano, outfit che sostituisce la corona che nel libretto Orontea lascia di fianco all’amato addormentato assieme a una lettera con cui lo fa assurgere al rango reale.
La regia è leggera e fluida, i personaggi sono giustamente individuati nei loro caratteri, i travestimenti e gli equivoci brillantemente risolti con Giacinta che si presenta come Ismero in tuta da motociclista e fa innamorare la vecchia Aristea, qui donna delle pulizie, mentre Tibrino è una voce femminile in completo maschile.
La musica non fa che commentare con eletta discrezione gli eventi. Qui non ci sono romanze, non ci sono recitativi secchi, è tutto un fluido recitar cantando che a tratti si rapprende in più melodici ariosi che il Maestro Giovanni Antonini realizza con consumata sapienza e gusto del colore strumentale a capo dell’orchestra del teatro fornita di strumenti storicamente informati. Il basso continuo è giustamente rafforzato per adattarsi alle dimensioni della sala del Piermarini, ma mai in nessun momento il volume sembra eccedere e il mantello sonoro disteso si adatta magistralmente ai momenti più seducenti, così come a quelli più leggeri e comici, a quelli di lamento oppure di passione.

Compagnia di canto di altissimo livello è quella messa insieme per questa esecuzione e tutti si dimostrano eccezionali attori. Stéphanie d’Oustrac (Orontea) è un’interprete raffinata che ben si adatta alla parte della donna i cui principi vengono spazzati via dalla subitanea passione. Talora la dizione fa un po’ difetto con quelle e finali pronunciate i. Il ruolo di Alidoro dopo essere passato da contralto a tenore è finalmente approdato a quello di controtenore e chi se non Carlo Vistoli poteva affrontare il personaggio di cui tutte le donne della vicenda si invaghiscono e che da reietto e straccione si insuperbisce quando gli viene offerta la possibilità di salire al trono, qui l’artista osannato che dispensa autografi al vernissage della sua esposizione. Una parabola millimetricamente realizzata la sua e una dizione da manuale, timbro sontuoso e grande musicalità sono le doti da sempre apprezzate in questo cantante. Il personaggio frivolo di Silandra trova in Francesca Pia Vitale interprete perfetta per sensualità e freschezza e suo è forse il momento più bello della serata, «Addio Corindo, addio», misto di nostalgia e fierezza. Corindo è Hugh Cutting, ottimo controtenore dal ricco timbro. Un po’ sprecata nella parte limitata di Tibrino è Sara Blanch. Maria Nazarova si dimostra efficace nel duplice ruolo di Giacinta/Ismero. Senza ariosi e con recitativi molto ridotti è il Creonte di Mirco Palazzi mentre Marcela Rahai e Luca Tittoto si impadroniscono delle immancabili parti buffe dell’opera secentesca: lei è Aristea, la vecchia ancora vogliosa, lui è Gelone che trova solo nell’alcol la consolazione di una vita da servo.
La regia è piena di dettagli teatralmente preziosi, come il brusio dei visitatori della galleria che impercettibilmente aumenta di volume fondendosi con la musica. Tocchi da maestro a cui Carsen ci ha da tempo abituati.
⸪