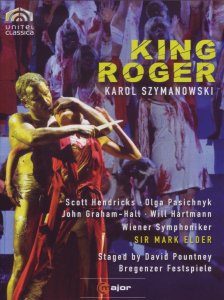© foto Ramella Giannese
Friedrich Händel, Giulio Cesare in Egitto
Torino, Teatro Regio, 25 novembre 2014
Una notte al museo
Miracolo a Torino: il suo ente lirico mette in cartellone un’opera barocca! È dal giugno 2009 che un titolo pre-mozartiano non viene allestito nella città capitale italiana del barocco e custode del maggior tesoro al mondo di manoscritti vivaldiani nella sua Biblioteca Nazionale a poche centinaia di metri di distanza dal Teatro Regio. Si trattava allora di un lavoro giovanile di Händel – Aci, Galatea e Polifemo – messo genialmente in scena al Teatro Carignano da Davide Livermore. Ma dobbiamo risalire ancora più in là nella storia del Nuovo Regio se vogliamo trovare un altro Händel (Tamerlano, 1997), un Monteverdi (L’Orfeo, 1996) e un altro Monteverdi (L’incoronazione di Poppea, 1977). Questo negli ultimi quarant’anni. Un titolo ogni dieci anni! (1)
L’immenso patrimonio musicale del Sei-Settecento (al 99% italiano) continua a essere assente qui da noi a conferma del ruolo di retroguardia culturale cui abbiamo deciso di condannarci. In questa stagione, ad esempio, delle opere di Händel saranno date 1360 rappresentazioni in 140 città estere. Nel mondo è il compositore più rappresentato dopo Bizet, molto più di Bellini e Massenet (fonte: operabase.com).
Questo Giulio Cesare in Egitto proveniente dall’Opéra National di Parigi (gennaio 2011) e ripreso qui da Laurie Feldman non basta certo a compensare la colpevole negligenza dimostrata dal nostro ente lirico e arriva sull’onda del grande interesse che questo repertorio desta invece al di là delle Alpi grazie a nomi quali Christie, Rousset, Gardiner, Jacobs, Minkowski – nomi quasi del tutto invisibili nei programmi italiani e torinesi in particolare.
Per quanto riguarda la messa in scena di quest’opera le nuove produzioni non possono prescindere dalla geniale regia che Peter Sellars ideò a Dresda nel 1990 con l’attualizzazione della vicenda e l’ambientazione nel moderno Medio Oriente. Nel 2012 Moshe Leiser e Patrice Caurier a Salisburgo andarono nella stessa direzione costringendo Cecilia Bartoli a intonare «Piangerò la sorte mia» in ginocchio, con le mani legate e incappucciata come nelle disturbanti immagini del carcere di Abu Ghraib. (Inutile dire che l’effetto è drammaticamente sconvolgente e la Bartoli superlativa come sempre: «Sei unica!» grida uno del pubblico).
Qui invece Laurent Pelly non sembra volersi invischiare in un discorso troppo impegnativo e quando invece del coro iniziale abbiamo la parata di teste di marmo che muovono la bocca in sincrono con la musica come nel Muppet Show si capisce il tono della serata e l’irriverente (azzardata?) commistione tra opera seria e opera buffa cui stiamo per assistere.
Anche se sembra siano stati il nostro Museo Egizio e le statue di Giulio Cesare alle Torri Palatine a ispirare Pelly quando nel 2009 allestì qui la sua Traviata tutt’ora in cartellone, quelli che vediamo sul palcoscenico del Regio sembrano piuttosto i depositi del museo del Cairo visto l’abbigliamento degli inservienti che senza posa spostano casse e reperti.
Questa è la scelta del regista francese per la sua prima regia di un’opera di Händel e diciamo subito che non è risultata troppo convincente e che Pelly sembra più a suo agio nel repertorio brillante e buffo – indimenticabile la sua irresistibile Platée di Rameau o il suo geniale Prokof’ev de L’amore delle tre melarance o ancora i suoi deliziosi Offenbach e Ravel. Non gioca a suo favore neanche il confronto col frizzante Giulio Cesare in stile Bollywood di McVicar a Glyndebourne di cui Carlo Majer nella presentazione dell’opera ha fornito gustosi esempi video.
L’idea di questo Giulio Cesare è un po’ quella del film di Shawn Levy dove Ben Stiller, guardiano notturno del National History Museum di New York, vede con stupore prendere vita i reperti là esposti. Intendiamoci, non che la sua messa in scena sia mal eseguita: le trovate sono sempre ironiche, i rimandi iconografici e le allusioni argute, ma quel continuo andirivieni in scena è talora fine a sé stesso, se non motivo di distrazione.
Questo horror vacui visivo e la ricerca di sempre nuove gag – dopo i reperti archeologici del primo atto, abbiamo infatti i quadri del secondo (e tra gli orientalisti e un Alma Tadema spunta anche un ritratto di Händel) e i tappeti orientali del terzo – portano presto a una certa sensazione di sazietà. Brutte le luci, come sono brutte le luci di un magazzino, mentre l’atmosfera un po’ claustrofobica non è stata alleviata dall’apertura sul fondo della scena che dà sull’esterno nel secondo atto. Indaffarato con tutte queste cianfrusaglie il regista si è dimenticato però della Personregie e le relazioni interpersonali tra i vari personaggi sono del tutto trascurate.
Il ruolo del titolo, interpretato al King’s Theatre di Londra il 20 febbraio 1724 da un idolo di allora, il castrato Senesino, è ora ricoperto da una voce femminile di contralto o da un controtenore (David Daniels e Andreas Scholl tra i più recenti esempi), ma c’è stato un tempo in cui il ruolo veniva abbassato di un’ottava e affidato a un baritono. (Dietrich Fischer-Dieskau ci ha lasciato un indimenticabile ricordo della sua interpretazione seppure con i tempi assurdi di Karl Richter e più recentemente anche il baritono Bryn Terfel ama inserire nei suoi recital l’aria «Va tacito e nascosto»).
Qui abbiamo Sonia Prina en travesti, cosa non insolita per il contralto magentino che si è spesso calato nei panni maschili degli Orlando, Rinaldo e Tamerlano handeliani o in quelli di Pompeo nel Farnace di Vivaldi o ancora dell’Ottone monteverdiano. L’eccellente vocalità è però percorsa talora da una certa disinvolta imprecisione nelle agilità e nell’intonazione. Non a caso è stata omessa l’aria più impervia di questo ruolo: «Quel torrente, che cade dal monte», terzo atto scena quinta.
Con Jessica Pratt abbiamo una Cleopatra quanto mai regale e ben diversa dalla esile Cleopatra della Dessay per la quale era stata cucita questa produzione a Parigi. Non sempre a suo agio è sembrata nelle scelte registiche che la fanno inerpicare su statue o casse ed è probabilmente dovuto a ciò un piccolo incidente di intonazione nella sua prima aria. Altrove la sua sontuosa vocalità non ne ha risentito e si è dimostrata come sempre fantasiosa nelle variazioni, fino a superare i limiti dello stile handeliano in certi acuti stratosferici. Gli abiti trasparenti – troppo trasparenti – ideati per il fisico minuto della Dessay sono stati adattati alla figura matronale della Pratt con risultati quanto meno discutibili.
Intensa come sempre anche se un po’ monocorde la Cornelia della Mingardo mentre meglio si è dimostrato il Sesto della Beaumont, vera rivelazione della serata. Dell’Achilla di Guido Loconsolo (lo stesso di Glyndebourne) sono stati ammirati solo i polpacci, del Tolomeo di Jud Perry nemmeno quelli. Anche a loro sono state tagliate alcune arie.
Talora il ruolo del confidente Nireno viene trasformato nella dama di compagnia Nirena (o Nerina). Il controtenore Riccardo Angelo Strano sembra abbia voluto imboccare qui una terza strada con i suoi atteggiamenti da figura parietale egizia che son piaciuti tanto al pubblico.
Ottima la prestazione dell’orchestra del Regio rimpolpata con alcuni strumenti antichi dell’Academia Montis Regalis di Alessandro De Marchi il quale ha diretto la compagine con competenza e precisione anche se si sarebbero voluti magari più colori per diversificare le arie e maggior sensualità nei numeri di seduzione della sovrana d’Egitto.
Il pubblico del Regio, dissuefatto a questo repertorio, è scemato un po’ durante gli intervalli lasciando ad applaudire comunque calorosamente nel finale un buon 70% degli spettatori iniziali.
(1) Ma non è solo con il compositore sassone che l’establishment operistico del nostro paese ha scarsa frequentazione: il Settecento italiano in Italia è ancora oggi quasi totalmente ignorato e per vedere un’opera dell’italianissimo Vivaldi dovremmo andare a Zurigo o a Braunschweig se non a Sydney).
⸪